16 Apr Mad about | Claudia Vanti
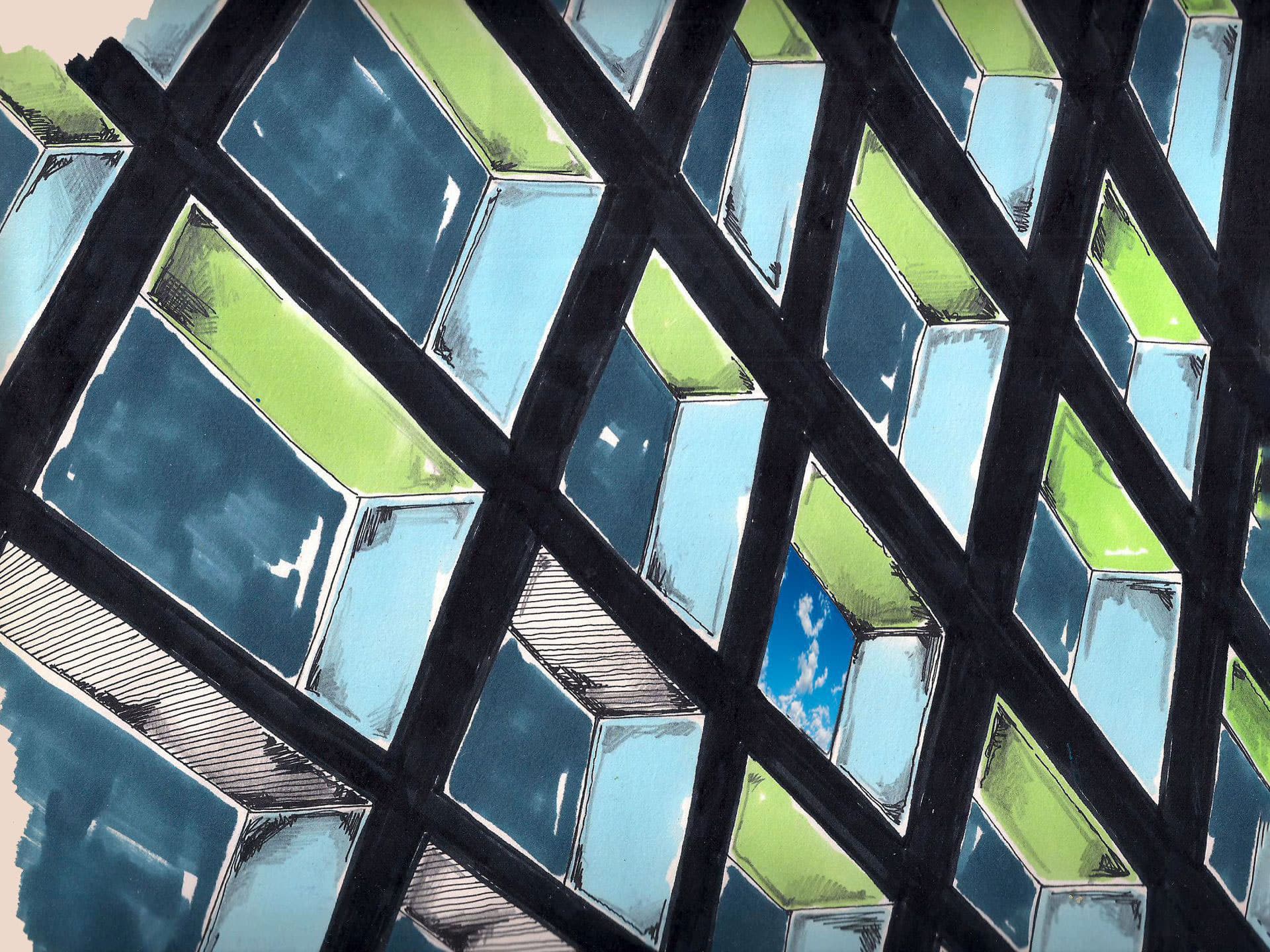
Ieri era la giornata del Made in Italy, una giornata appositamente istituita da questo nostro vivace governo prodigo tanto nell’invenzione di celebrazioni quanto di nuovi reati.
Come se non ce ne fossero già abbastanza di giornate celebrative, dedicate a qualsiasi anniversario e/o promozione di eventi, prese di coscienza di problemi vari, buone intenzioni e buone cause, avvenimenti storici drammatici e curiosità bislacche: giornata della traduzione, della tigre, del patrimonio, della mole (l’unità di misura), dell’infanzia, del sonno, della felicità (20 marzo, tutto il resto dell’anno: afflizione), degli scacchi, della biodiversità e degli asteroidi.
Eccetera.
Di Made in Italy (ricordato perché è scomparso? Tenuto d’occhio perché è pericolante? O perché è problematico?) è quella cosa di cui si parla sempre tanto sempre a caso: ci hanno detto che è un’eccellenza per cui ci siamo conosciuti nel mondo, che è qualcosa di cui andare fieri… ma è un’etichetta sempre più generica e approssimativa, usata per sentito dire se non direttamente abusata.
Tecnicamente è un’indicazione di provenienza , che regolamenta anche l’origine del processo produttivo o della maggior parte di esso, ha una storia abbastanza lunga che è diventata di massa a partire dagli anni ’80 , in pratica una sorta di etichetta commerciale equivalente all’ Italians Do It Better di Madonna.
Infatti la denominazione si è diffusa nel linguaggio comune prima negli States, e già nel 1965 Diana Vreeland in un famoso servizio di Vogue dedicato ai creatori italiani aveva scritto delle didascalie mettevano in luce una certa specificità, di stile e “manufacture”.
Poi, complice il boom economico degli anni ’60 e la Milano da bere degli anni ’80, il bacino del Made in Italy si è allargato , arrivando a comprendere il design e d’arredamento, le automobili ma anche, ça va sans dire, l’agroalimentare , il cibo o, meglio, il food.
La banalizzazione di queste etichette, la ripetizione ossessiva, come se fossero dei mantra salvifici, svuota di contenuto la progettualità e la manifattura ne sono alla base.
Dietro tutte le discussioni, le valorizzazioni che sono prese di posizioni demenziali come l’idea di far cambiare nome a un’auto (non più Alfa Milano ma Junior perché non interamente prodotta in Italia), la promozione superficiale (attenzione che a qualcuno non venga in mente di decretare il cambio di nome per la zuppa inglese o le calze parigine, poco nazionaliste) e il nuovo liceo del Made in Italy (ridicolizzato dagli studenti stessi che non si sono iscritti) rimane soprattutto un guscio vuoto da celebrare senza conoscerlo e da promuovere per stereotipi.
Negli States però la banalità dello stereotipo piace, amano come tutti ricevere conferme e ritrovare le cose a cui sono affezionati, con un effetto The White Lotus, comfort style rassicurante: quello gli diamo e quello promuoviamo, salvo poi arrabbiarci quando ci accorgiamo che è un cliché.
Chiacchiere e cliché , beh è sempre meglio di “chiacchiere distintivo” (cit. Capone ), ma Leo da Vinci (è dalla sua data di nascita che deriva la scelta della data del 15 aprile) è improbabile che amasse i cliché, forse avrebbe preferito qualcosa di più sperimentale e irregolare, addirittura un po’ “Mad”.
