
L’ideale di perfezione del mondo ellenico era espresso in due parole – bello e buono, semplificando – che si fondevano in un concetto unico, kalokagathìa, e cioè l’unione di bellezza e di spirito virtuoso che portava alla perfezione dell’essere umano e che si tentava di rappresentare attraverso l’arte.
Non esiste una parola che traduca perfettamente questo binomio, non solo nella lingua italiana ma in molte altre lingue, probabilmente perché da tempo si è rinunciato all’idea che “bello e buono” possano convivere o addirittura fondersi in un’espressione unitaria.
Volendo ci sarebbe comunque da discutere sulle motivazioni che avevano portato gli artefici del pensiero greco, Platone in testa , a elaborare un simile concetto: non partiva certamente da premesse particolarmente inclusive e democratiche, però sta di fatto l’unione di estetica/aspetto esteriore e virtù/qualità morali abbia attraversato parecchi secoli rappresentando un ideale assoluto.
Il Novecento è il secolo che si è allontanato di più dall’aspirazione a questo tipo di perfezione, sommerso dal vortice consumistico derivato dalla seconda, e poi terza o quarta rivoluzione industriale: il bello, o presunto tale, e la gratificazione immediata che prometteva, sono stati un fine per il cui raggiungimento si è fatto letteralmente terra bruciata di risorse e materie prime.
Poi, fuori tempo massimo, è partita la rincorsa al “buono”, all’aspetto morale chiamando in causa prima di tutte le Industrie creative (soprattutto la moda, che sconta lo stigma ontologico di frivolezza, molto meno altri settori del design, più “maschili” e con un credito di autorevolezza chi si estende fino alla più inutile oggettistica).
Solo che il “buono si sta concretizzando in una sorta di dilavamento generale della coscienza tramite un greenwashing diffuso e nella maggior parte dei casi accettato pur se riconosciuto come tale.
Ma lo slogan , perché a questo punto è uno slogan, Kalòs kai agathòs, torna buono come statement di approccio etico , appoggiandosi da un lato sul retaggio della cultura cattolica e delle religioni in generale che non vedono mai di buon occhio la pura estetica votata all’apparenza parentesi (a meno che non sia un tripudio di ricchezze dedicate a culti e rituali) e dall’altro su un certo neo moralismo manicheo che cerca soluzioni facili, instagrammabili e apodittiche.
E quindi possiamo continuare a sommergere il pianeta di oggetti inutili, manufatti improbabili in lana ai ferri o all’uncinetto, bijoux realizzati con qualsiasi tipo di materiale residuale, capi d’abbigliamento assemblati male e cuciti peggio che però sono “buoni” e sono realizzati per la salvezza del pianeta, ma dimenticando una cosa fondamentale: per quanto si possa promuovere “agathos”, il solo lato etico delle cose non regge, e nel giro di pochissimo tempo, dopo aver assolto l’obbligo morale di un acquisto etico che ci faccia sentire un po’ meno male durante l’impulso consumista, tenderemo a dimenticare quell’oggetto, quella maglia, quella sciarpa, quel paio di orecchini storti in un cassetto, dimenticarcene fino a quando non diventeranno essi stessi rifiuti.
Perché il “kalòs” è soggettivo, certo, ma se è prevaricato dall’altro soggetto della coppia perfetta l’equilibrio non si raggiunge, anzi si rompe, cade rovinosamente a terra e non ci resta che raccogliere ancora più cocci.
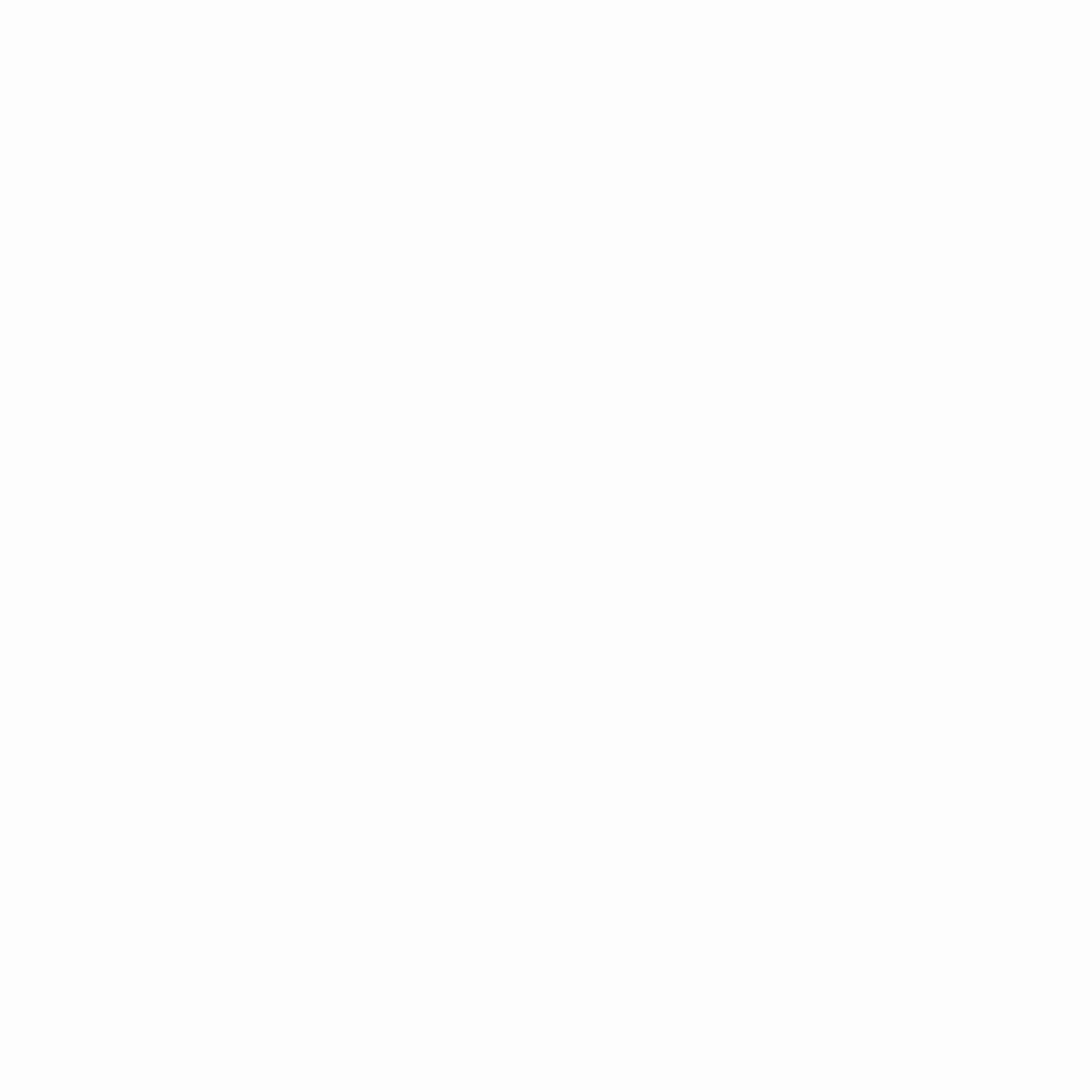
CLAUDIA VANTI
Stilista eclettica, ha collaborato per anni con marchi del pret à porter italiano e internazionale come Ferré, Chanel, Hugo Boss.
Insegna Design del Prodotto moda, ha la passione del disegno e il sogno segreto di scrivere la sceneggiatura di una serie tv. Ovviamente sulla moda.
